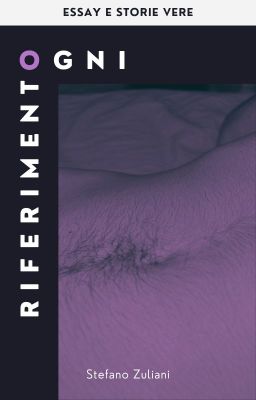Il cortile sembra di un condominio del Bronx, con i terrazzi degli appartamenti che affacciamo all’interno su uno spiazzo enorme dove l’erba non cresce neanche. Ci sono due poliziotti in un terrazzo al pianterreno che mi guardano male quando mi avvicino. Poi finalmente scende N. e mi indica la bicicletta. È così messa male che dalla foto non l’avevo neanche riconosciuta. Ha il telaio giallo ocra, le gomme di due colori diversi e dei pezzi di nastro adesivo fucsia intorno al manubrio e alla sella.
«Ha il freno davanti staccato,» mi dice, «ma c’è un biciclettaio qui in corso Palermo che te la ripara con poco.»
Me la fa provare. Certo, non frena, ma per il resto cammina benone. D’accordo, con sessanta euro mi porto a casa la bici e pure la catena.
Mentre la spingo sul marciapiede penso che era esattamente quello che cercavo da settimane e non riuscivo a trovare: una bicicletta solida, veloce e soprattutto economica. Colpa mia, che non mi sono mai convinto a svegliarmi presto il sabato per andare al Balôn prima che tutte le bici decenti se le siano prese.
Mentre torno la provo di nuovo, con solo il freno posteriore. Penso a quanto sono fortunato, e che Granovetter aveva proprio ragione sulla forza dei legami deboli (perché, anche se frequentiamo gli stessi posti, N. l’avrò visto in totale quattro volte).
Solo alla fine corso Giulio butto un occhio, e mi accorgo che la forcella che collega il telaio alla ruota anteriore è spezzata.
«Ma è riparabile?»
Il giorno dopo mi sono fermato da Beppe della ciclofficina Cycles, sul Lungo Dora. È quasi il tramonto, lui ha molto lavoro e comunque in generale è un tipo un po’ burbero. Sulla bicicletta ci sono andato in giro tutta la mattina, sfidando la sorte e ignorando rumori ambigui e strani saltelli, e nel frattempo finisce che mi ci sono affezionato.
«Me l’hanno lasciata in questo stato, ma a buttarla mi dispiace…»
Beppe è un tipo giovane, coi ricci afro e sempre i guanti da lavoro. La guarda un po’ da vicino. «È una bella bicicletta, non va buttata,» mi dice. «Però ci va tanto lavoro…»
«Tipo?»
«Una sessantina di euro… a trovare la forcella e tutto, almeno quattro giorni.»
«E va be’» – che poi a questo punto sarei disposto a mettercene su anche centocinquanta di euro ma ovviamente non glielo dico. Non vuole un acconto, non vuole niente, se non mettere in chiaro che io di biciclette non ne capisco nulla (che è assolutamente vero, tanto più che l’ho comprata).
Me ne vado via a piedi per il lungo Dora, sollevato come se volassi, e sono impaziente di girare col nastro adesivo fucsia da tutte le parti. Tutto si ripara alla fine. Un po’ come quei giapponesi che mettono l’oro nel vasellame rotto. Non è tanto il risultato, quanto l’investimento.
In fondo è un po’ come Wiz, che è il mio computer. Oggi ci lavoro tutti i giorni, è adatto a me, ai miei gesti e alle mie scorciatoie mentali. Ma quando è arrivato, nell’estate nel 2023, era solo una bizzarra macchina ricondizionata, con una RAM esagerata e uno schermo touchscreen imperfetto e del tutto superfluo. Per di più, la batteria era stata montata fuori posto, e sono occorsi un po’ di tentativi per riuscire se non altro ad accenderlo. Poi, sul più bello che avevo installato il sistema operativo, avevo scoperto di un raro problema di kernel che alcune macchine potevano incontrare con la mia distro di Linux.
«Ma è riparabile?» mi chiedevo, perché non avevo nessun altro a cui chiederlo. Per una settimana avevo pensato che fosse insalvabile. Di nuovo colpa mia e della mia poca pazienza. Ema, che con internet è zen, era riuscitə a trovare su un forum uno che aveva avuto lo stesso problema e che si era inventato lì per lì una soluzione. Questo mi aveva salvato il computer e mi aveva definitivamente convinto della tesi di Ivan Illich sul potere della comunità di fare a meno del giudizio degli esperti. Insomma, dopo momenti di panico ce l’eravamo cavata bene.
Solo adesso mi torna in mente che, una volta riparato, uno dei nomi che avevo pensato di dare al computer era Oscar.